“La ricerca sul campo deve cambiare in risposta al Covid-19”. Lo sostiene Andrea Zerboni, geoarcheologo e docente presso il Dipartimento di scienze della terra ‘Ardito Desio’ dell’Università degli studi di Milano. Insieme a un gruppo internazionale di colleghi, ha riflettuto su come continuare le ricerche sul terreno in tempo di pandemia, con le possibilità di viaggiare e lavorare con altri pressoché azzerate. Il risultato è una sorta di manifesto pubblicato sulla rivista scientifica Nature Ecology and Evolution.
Non bisogna aspettare un ‘ritorno alla normalità’ – sostiene il manifesto – ma costruire un nuovo modello di ricerca. E bisogna farlo subito: coinvolgendo pienamente i colleghi che vivono sul posto, usando di più la tecnologia e stringendo reti di collaborazione.
Professor Zerboni, perché l’attività ‘sul campo’ è importante?
Perché è il punto di partenza per ogni attività di ricerca in ambito archeologico, geologico e biologico. Si parte sempre dall’attività sul terreno, da quando si va sul campo e si inizia un’indagine, una ricognizione o uno scavo.
Cos’è successo con il diffondersi della pandemia di Covid-19?
Tutto si è bloccato di colpo con il lockdown. Si sono fermate le ricerche già previste e si è interrotta la programmazione di altre attività sul terreno, che generalmente vengono progettate con molti mesi di anticipo. L’impressione era che sarebbe stato difficile riprendere anche in estate e in autunno.

Erg Tannezuft, Libia. Andrea Zerboni con il suo maestro Mauro Cremaschi e la direttrice di Archeostorie Cinzia Dal Maso. Foto Teodoro Teodoracopulos
Com’è oggi la situazione delle ricerche sul campo?
È irrealistico e rischioso pensare di svolgere attività all’estero. Molti colleghi lavorano in vari Paesi mediterranei, nel Vicino Oriente, in Africa o in Asia, spesso in aree rurali difficili da raggiungere; io stesso seguo progetti in Sudan, Etiopia, Oman e Kurdistan. Ovunque la situazione sanitaria è complessa e le informazioni sull’epidemia non sono complete né affidabili. Diventa perciò difficile tutelare la sicurezza dei ricercatori, degli studenti e delle comunità locali.
Ma ci sono anche altri ostacoli: alcuni Paesi richiedono costose assicurazioni sanitarie, o settimane di quarantena all’arrivo; in altri si potrebbe anche pensare di tornare abbastanza presto, ma se dovesse scattare un nuovo lockdown qui o là, cosa potrebbe succedere con i voli e i rientri? Ovviamente, oltre al Covid, ci sono altri fattori che bloccano il lavoro di ricerca: l’instabilità sociopolitica, i colpi di Stato, i conflitti.
Fortunatamente svolgiamo anche attività in Italia e da maggio, con la fine del lockdown, abbiamo ripreso gli scavi di archeologia preventiva, svolti da professionisti e legati alla costruzione di edifici e infrastrutture. A giugno abbiamo persino cominciato a organizzare uno scavo universitario in un sito dell’età del bronzo nella pianura padana. Certo, è stato molto faticoso a causa delle restrizioni e abbiamo coinvolto solo poche persone, ma abbiamo dato un bel segnale alla comunità e agli enti locali. So che sono comunque pochi gli scavi universitari condotti quest’anno, o in programmazione.
Ci può raccontare come è nata la vostra riflessione, pubblicata su Nature Ecology and Evolution.
Con un gruppo di colleghi di varia provenienza, abbiamo provato a ragionare in un’ottica internazionale. Ci siamo detti: abbiamo progetti in corso, già finanziati, e non sappiamo cosa succederà; gli studenti che stanno facendo una tesi di laurea o di dottorato rischiano di perdere un anno di attività. Così ci siamo riuniti in videoconferenza per discutere insieme del problema.
Cosa proponete, per portare avanti le attività sul campo?
Maggiore collaborazione e coinvolgimento delle comunità locali, di chi vive cioè nei Paesi dove si svolgono le ricerche. I ricercatori delle istituzioni locali possono condurre le ricerche sul campo e poi condividere i risultati da remoto con tutto il gruppo di ricerca internazionale. Questo implica però una formazione appropriata di tali ricercatori, magari anche a distanza, e un maggiore utilizzo delle tecnologie.
Certo, non tutto si può fare da remoto, però si possono minimizzare le necessità di andare sul terreno. Invece di mobilitare gruppi molto ampi di ricercatori, ci si limita a una o due persone, mentre sono i ricercatori locali a seguire tutta l’attività sul terreno: lo scavo, la gestione dei materiali, la raccolta della documentazione e la messa a disposizione dei dati ottenuti, così che possano essere visti da tutto il team e discussi insieme.
Non è un processo facile e le difficoltà sono molte. Innanzitutto, in alcuni Paesi non ci sono ricercatori locali competenti per portare avanti le ricerche. Anche se oggi numerosi progetti di ricerca comprendono la formazione dei colleghi locali, questo richiede molto tempo. Bisognerebbe inoltre fornire loro la strumentazione tecnologica adeguata, perché spesso non possiedono i fondi per procurarsela.

Preparazione al rilievo topografico in un sito archeologico dell’Etiopia meridionale. Foto Andrea Zerboni
Questo modello di ricerca porta conseguenze anche per l’ambiente.
L’impatto ecologico delle ricerche sul campo è importante: gruppi numerosi di persone si muovono, spesso con voli intercontinentali, e vanno a lavorare in un ambiente naturale. Riducendo la mobilità, diminuirebbero anche le emissioni di CO₂ legate alla ricerca.
Quali soluzioni tecnologiche possono venire in aiuto?
La fotogrammetria si sta sviluppando molto: tramite le fotografie, ricostruisce in modo sempre più affidabile la tridimensionalità delle sezioni stratigrafiche del terreno o degli oggetti di cultura materiale. È partita una vera corsa a trovare soluzioni tecnologiche per rendere disponibili gli oggetti senza esportarli, o le sezioni stratigrafiche senza doverle vedere dal vero.
Ma come mettere questi dati a disposizione di tutti?
I ricercatori devono abbandonare una volta per tutte l’idea della proprietà privata dei dati, devono cambiare mentalità. Alcuni non mettono a disposizione i dati grezzi per gelosia o per timore che se ne traggano considerazioni diverse dalle loro. Ora però si stanno diffondendo sempre più i repository di dati, cioè dei database online dove ognuno può caricare i propri dati, che siano già pubblicati o no, e metterli a disposizione della comunità scientifica.
L’altra faccia delle open sciences è l’accessibilità alle pubblicazioni scientifiche. In Europa c’è un buon accesso perché le istituzioni pagano l’abbonamento alle riviste scientifiche per i ricercatori. In altri Paesi invece non ci sono le risorse, quindi gli studiosi hanno un grosso problema di accesso all’informazione.
Quanto è già diffuso il lavoro di rete tra ricercatori e la collaborazione tra più istituzioni?
Dipende molto dalle persone: c’è chi è abituato a lavorare in modo solitario e chi in équipe più o meno ampie. Ora però le competenze sono talmente specialistiche che, per fare un discorso globale e completo, spesso si è obbligati a lavorare in squadra e a fare rete, non soltanto all’interno dello stesso istituto ma a livello nazionale e internazionale. Mi capita sempre più spesso di collaborare con altri colleghi per un obiettivo comune, ognuno per il proprio ambito di competenza. Alcuni però sono ancora restii a condividere un risultato finale o il merito di una scoperta. Sono gelosi del proprio lavoro: è un atteggiamento comprensibile, ma che va superato.

Indagine geofisica per trovare resti archeologici sepolti presso la cittadella di Salut nell’Oman centrale. Foto Andrea Zerboni
Questo modello, fondato su una maggiore collaborazione con le comunità locali, può rappresentare un passo in avanti nella ‘decolonizzazione’ della ricerca? Oggi non solo il Covid, ma anche il movimento Black Lives Matter sta imponendo di ripensare prassi consolidate ma eticamente non più sostenibili, come sottolinea anche l’American Institute for Archaeology in una recente dichiarazione.
Sono due facce della stessa medaglia. È innegabile che ci sia stato per decenni una sorta di ‘colonialismo’ scientifico, ovvero dal Nord globale i ricercatori andavano nel Sud globale a svolgere le loro ricerche, senza coinvolgere i ricercatori locali. All’inizio magari non c’erano, per cui non si ponevano neppure il problema di formarli, o magari c’erano le competenze in loco ma non c’era la volontà di lavorare insieme. Negli ultimi anni, però, questa tendenza sta cambiando, e di sicuro movimenti come il Black Lives Matter danno un’ulteriore spinta in questa direzione.
Nelle mie esperienze di ricerca, gli studiosi locali sono stati sempre coinvolti. In Etiopia, per esempio, i colleghi locali sono pienamente coinvolti e attivi, e portano avanti le ricerche sul campo. Ma non è sempre così, e c’è anche un problema di interesse che in alcuni Paesi è meno forte o non c’è.
Tuttavia alcuni colleghi africani vedono la nostra proposta come un’opportunità di crescita e di mettere a frutto le loro competenze, come prima non era possibile fare per carenza di finanziamenti o altri problemi. Sarebbero veramente contenti di far crescere un modello come questo di collaborazione più ampia e di maggior coinvolgimento.
Qual è il primo cambiamento necessario per andare verso questo modello di ricerca?
La formazione. Bisogna trovare tempo e finanziamenti per programmi di scambio tra ricercatori che siano a più ampio respiro. Sono già attivi progetti europei per scambi con tutto il mondo: giovani ricercatori e studenti di altri Paesi imparano metodologie e sviluppano competenze venendo in Italia o altrove. Ma questo strumento va amplificato e migliorato.
Ci dev’essere maggior possibilità di mobilità non dal Nord globale al Sud globale, ma viceversa. E bisogna aumentare le occasioni di formazione nei Paesi dove si svolgono le ricerche. Perché formarsi altrove dà di più dal punto di vista strumentale: una cosa è apprendere tutto solo in teoria, un’altra è utilizzare uno strumento o un metodo e poter fare pratica. Purtroppo in alcuni Paesi del Sud globale in questo momento è difficile andare oltre la teoria.
So che la nostra proposta può sembrare idealistica, una bella utopia. E sappiamo bene che sono processi molto difficili da mettere in pratica. Però da qualche parte bisogna iniziare. Il mondo tutto sta evolvendo, e anche la ricerca deve provare a migliorarsi!







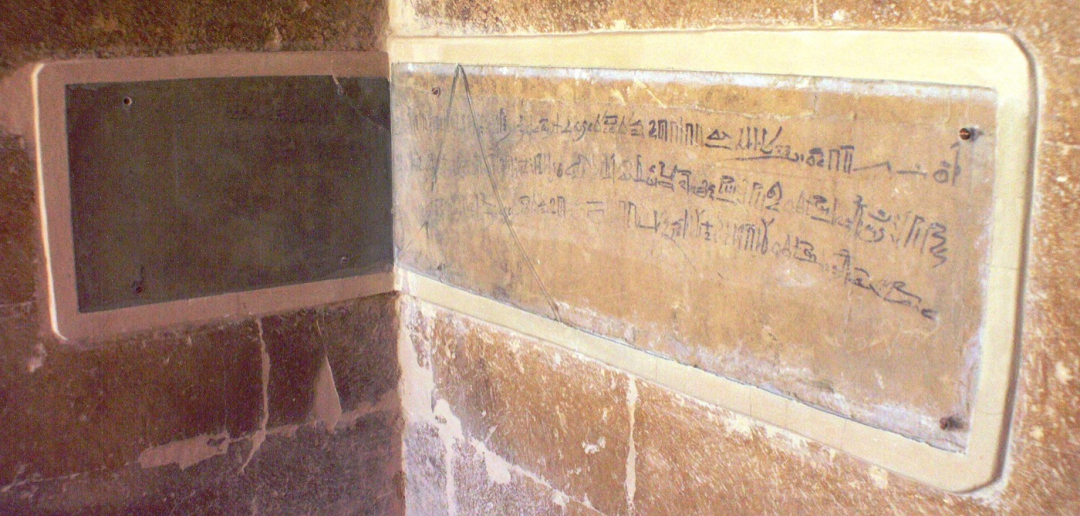

0 commenti